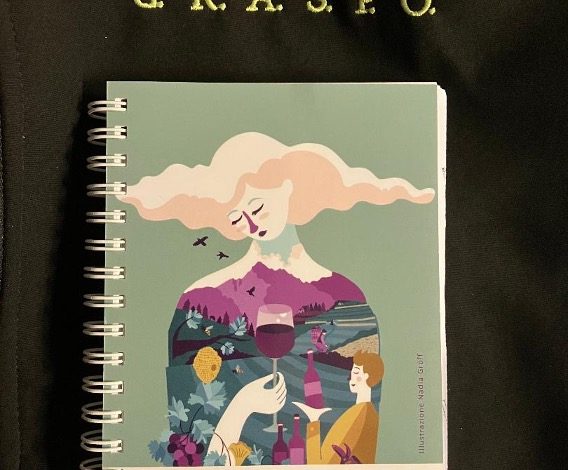
VINIFERA – Trento, sabato 22 e domenica 23 Marzo 2025
Trento è città che per anni è stata votata e decretata come uno dei comuni italiani dove si vive meglio. Passeggiando per la città lo si percepisce, contornati da bellezze architettoniche e un clima disteso e rilassato che si respira camminando tra le vie ed i vicoli cittadini.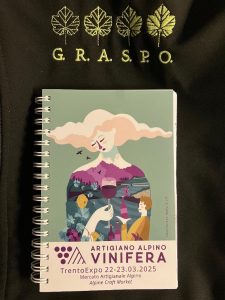
GRASPO doveva esser presente a questa nuova edizione di VINIFERA – artigianato alpino.
Purtroppo solitario, e non con il consueto seguito che le spedizioni di GRASPO effettuano in giro in Italia, sono stato piacevolmente accolto anche quest’anno dalla rassegna trentina.
Un ringraziamento va certamente all’Associazione Centrifuga, che ha organizzato l’evento, coadiuvati da WellCom, insieme alla Regione, la provincia autonoma di Trento e il Comune.
Il tempo minacciava pioggia nella due giorni, così la logistica interna ha subito necessarie scelte per dar modo a tutti, sia i vignaioli, sia gli espositori dell’alimentare ed artigianato, di poter fruire di spazi coperti e sicuri. Così quest’anno i vignaioli di trovavano al piano interrato dell’area espositivo di Trento Expo.
Un po’ più di illuminazione ed aerazione sarebbe stata necessaria, visto l’enorme numero di persone presenti nella giornata già di sabato.
Tanti partecipanti e banchi sempre abbondantemente contornati da visitatori curiosi e spesso preparati. È da notare come ci fosse un’età media abbastanza bassa, così da testimoniare l’interesse per i giovani per questo affascinante mondo.
L’offerta della mostra mercato ha dato modo di spaziare dall’arco alpino, così come normalmente inteso, toccando alcune tematiche nelle masterclass proposte: da montagna vista mare ai vini PIWI, da Reis-istenze alpine alle piccole isole, sostanza mediterranea.
L’interesse di GRASPO mi ha portato prima di tutto a salutare alcuni amici vignaioli graspisti presenti. Poi la curiosità ha preso il sopravvento e sono passato ad assaggiare le svariate proposte enologiche da vitigni minori, rari e dimenticati. Il banchetto di Lorenzo Zadra e sua moglie Gloria era spesso pieno per assaggiare il suo iconico Groppello di Revò. 
El Zeremia è certamente correlato con il recupero e valorizzazione di questo vitigno, che propone in una versione piacevole e beverina (solo acciaio) e una più strutturata con passaggio in legno. Oltre alle varietà resistenti che Lorenzo da anni ha deciso di portare in Val di Non, vedo una bottiglia di Maor, che timidamente compare dalla glacette.
Mi dice che ne ha portate solo 2, poiché quest’anno la produzione è stata così difficile da esser riuscito a produrre il 50% in meno rispetto all’annata 2023.
Vino piacevolissimo e immediato, che sconta una delicatezza ed estrema difficoltà di gestione in vigna, oltra ad una sua peculiare sensibilità vegetativa, alle malattie ed alle azioni meteorologiche.
Stefano Turbil, anima de La Chimera Viticultura Eroica, ha portato la famiglia che lo aiuta non solo dietro al banco. La moglie Mariangela e il giovane figliolo, controllato dalla sorellina, versano calici di autentico lavoro eroico montano, dove l’Avanà è il vitigno simbolo della loro produzione a Chiomonte (TO).
Sempre piacevole il suo AE, Metodo Classico da Avanà. Il Bau è invece il loro assemblaggio tra Barbera e Becuet, altra rarità del Nord Piemonte. Stefano mi dice di aver completato un lungo lavoro di sistemazione dei terreni che pian piano entreranno in produzione, per integrare i suoi attuali 3 ettari, vigneti conquistati all’avanzamento dei boschi, che vanno curati e custoditi, non abbandonati.
Vedo poi un vitigno caro a GRASPO come la Pavana, ma qui in espressione più orientale: siamo nel Feltrino da Claudio Polesana, che propone Radiosa Aurora 2021, un rifermentato da Pavana certamente gradevole e di buona bevibilità. Poi con il Terra, versione ferma di un rosso certamente più strutturato che fa un passaggio in anfore Demetra, donando una buona freschezza. Qui si possono assaggiare anche alcune declinazione di Bianchetta e assemblaggi da altre uve locali.
Passando a vignaioli locali o certamente attigui al Trentino, mi soffermo sul Frauler, vitigno a bacca bianca che si testimonia sia presente in Sudtirolo da oltre 400 anni. Befehlhof, azienda di Silandro (fraz. Vezzano) in provincia di Bolzano, lo presenta nel vino Jera.
Poi vedo un altro vitigno certamente non così raro, ma assolutamente poco noto e in parte dimenticato come lo Zweigelt, vitigno a bacca nera storicamente fermatosi in Alto Adige, e qui in una proposta lineare.
Avrei voluto comparare quest’ultimo vino con l’omologo di Rielinger (Renon-BZ), ma non lo avevo portato. Ho però l’opportunità di assaggiare una vera rarità: un Blatterle, vitigno a bacca bianca di cui questo vignaiolo credo proprio sia l’unico a produrlo in purezza.
Vigna antica che ricorda una lontana Nosiola per le note aromatiche e uno Pinot Bianco per corpo.
Fino ad una cinquantina di anni fa era tra i vitigni a bacca bianca principali della Valle Isarco: ora praticamente scomparso. C’è un progetto nei vini Cometa di Alois Lageder che potrebbe rilanciarlo e darne nuova considerazione.
Scendendo e tornando in Trentino a Novella, fraz. Romallo, Laste Rosse ha una sua interpretazione del Groppello di Revò, che si esprime sia in versione Metodo Classico 48 mesi sui lieviti (vinificato in bianco), sia come rosso fermo. Entrambe corrette e pulite.
Curioso poi trovare del Pinot Nero, con vinificazioni analoghe al Groppello e un Gewurztraminer; meno un Solaris che ben si comporta a 700 metri s.l.m.
La Valle d’Aosta è spesso lasciata ai margini, non solo per la sua posizione geografica e le ridotte dimensioni. A parte 3 o 4 vitigni tipici, gli altri territoriali lo sono altrettanto, ma così poco prodotti e coltivati, che passano in sordina. A Saint Christophe, sulle colline attorno ad Aosta, Matthieu Betemps produce una Petite Arvine ferma e secca, dritta, schietta e netta, come autenticità del vitigno alpino. Un Mayolet piacevole al palato e di bella bevibilità.
C’è poi un assemblaggio interessante nel suo Rouge Le Rive, dove il Fumin è unito al Gamaret, vitigno a bacca nera ormai decisamente raro, nonostante la sua piacevolezza e spiccata fresca bevibilità. Vino centrato e godevole.
Poi una decisa curiosità: il vino rosso Merci, ottenuto da vecchie vigne di Barbera. Dovrebbe essere un unicum, tenuto conto che anni fa venne decretato non più piantabile e vinificabile questo italico vitigno, che si diceva poco fosse rappresentativo e specifico di questi territori.
Invece, dopo l’assaggio di questo vino, direi proprio sarebbe un peccato estirpare una vigna di oltre 70 anni che produce poco, ma una vera chicca enologica di raffinato e misurato pregio.
Scendendo e passando dal Piemonte, entriamo in Liguria e ci affacciamo sulla sponda di Ponente. Terrazze Singhie è una piccola realtà nata pochi anni fa dalla caparbietà di una giovane coppia che ha voluto riconquistare terreno al bosco, tanto da ripulire un antico vigneto tra i rovi, dove oggi campeggia un piccolo appezzamento di Lumassina di Bosco.
Il vino risente del terreno ricco di scisto, sabbia e limo. Vino leggero, teso e vibrante, con note lievi di erbe aromatiche.
Completano la gamma delle 4.000 bottiglie complessivamente prodotte, il Vermentino che è proposto tra i TreCrù ed una espressione ben diversa e distinta con altri 2 vini, dove i vigneti si trovano però nella marittima Ceriale, quindi a livello del mare.
All’assaggio il vino mostra tutte le sensazioni salmastre di questa vicinanza.
Spostandosi nella provincia di Imperia a Pornassio, l’azienda Lorenzo Ramò mantiene le tradizioni sui vitigni locali; così il bianco di entrata e beverino è la Lumassina, per poi spaziare tra Pigato, Vermentino e Sciac-Trà, sino ad arrivare all’emblema dell’Ormeasco, storica bandiera dell’azienda che fu. Un’altra realtà eroica è quella di Daniele Ronco, che sconsolato mi dice: “ma chi me lo fa fare a tenere ancora questa Granaccia?
Mi costa un sacco di lavoro, enorme rischio per la sua suscettibilità e poi ho una resa così bassa, che è veramente anti-commerciale”. Però il vino è decisamente buono e accattivante; c’è da ringraziare questo giovane che mantiene viva una tradizione per un vitigno in lento declino di consenso, non solo sul Ponente ligure.
Meno male che il Pigato, ben fatto, aiuta il sostentamento che con complessivamente 9.000 bottiglie rende non sempre agevole proseguire, ma entusiasmo e qualità guidano questa piccola azienda.
Due distinti excursus sono i vini dell’Isola d’Ischia e di Salina. I primi sono quelli di Cenatiempo, azienda familiare decisamente territoriale, che propone il Forastera, una Biancolella in due versioni, di cui la selezione Kalimera emerge in maniera netta e sostanziosa.
Tra le uve a bacca nera, ottenute da diversi appezzamenti isolani, ci sono il Piedirosso o Per’ ‘e Palummo, Guarnaccia e altre piccole percentuali di vitigni isolani come Catalanesca, Lentisco e altri, che concorrono nell’assemblaggio dell’Ischia Rosso.
Una coppia affabile mi accoglie da Cantine d’Amico, azienda della splendida isola di Salina. Un banchetto dove i capperi e il sale sono in primo piano con lo sfondo dei vini.
La Malvasia secca è certamente un pezzo forte: vino pieno e fresco, giustamente aromatico nella sua versione secca, dove emerge tutta la sua solarità. La cortese signora mi chiede di pizzicare una ciotola dove è pestato un trito di sale grezzo e capperi sminuzzati, che mi suggerisce di porre sulla punta della lingua.
Poi mi versa un vino di color rosa antico con sfumature di buccia di cipolla. Potrebbe ricordare un Pinot Grigio ramato, invece è Ambra Salina Bianco IGT, vino ottenuto da Inzolia, Catarratto e Malvasia unitamente ad altre uve endemiche, con sensazioni assolutamente lontane dagli stereotipi siciliani classici.
Analoga considerazione per il Salina Rosso IGT Tenuta Ruvoli, da uve Nerello Cappuccio e Mascalese più un 10% di antiche uve locali di cui alcuni nomi rimangono dialettali, altri tramandati e non censiti ufficialmente. A chiudere l’emblematica Malvasia delle Lipari Passita, dove come da tradizione, alla Malvasia c’è un 10% di Corinto Nero.
Una due giorni intensa con tanti assaggi e molti scambi di pareri ed opinioni.
Mi piace sottolineare che esser riconosciuti anche come GRASPO non solo dai vignaioli, è sintomo che quanto seminato sta iniziando a germinare.
Se non solo i tecnici e gli addetti ai lavori conoscono e parlano di GRASPO vuol dire che i vitigni meno noti e recuperati stanno destando interesse e curiosità anche da parte dei consumatori e degli appassionati al mondo di Bacco.
di Ivano Asperti……E il viaggio continua
Grazie per aver letto questo articolo...
Da 15 anni offriamo una informazione libera a difesa della filiera agricola e dei piccoli produttori e non ha mai avuto fondi pubblici. La pandemia Coronavirus coinvolge anche noi. Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, è semplicemente ridotta e non più in grado di sostenere le spese.
Per questo chiediamo ai lettori, speriamo, ci apprezzino, di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, può diventare Importante.
Puoi dare il tuo contributo con PayPal che trovi qui a fianco. Oppure puoi fare anche un bonifico a questo Iban IT 94E0301503200000006351299 intestato a Francesco Turri





